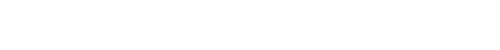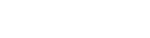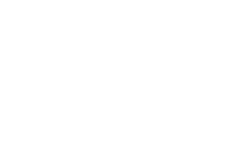PM10, ozono e biossido di azoto non accennano a diminuireIl trasporto pubblico caratterizzato da luci e ombre
Circa il 75% della popolazione europea vive in aree urbane e si stima che tale quota entro il 2020 raggiungerà un valore dell’80%, determinando un progressivo deterioramento dell’ambiente di vita e una crescente pressione sugli ecosistemi.
Per questo motivo l’osservazione continua di quanto avviene in questi importanti ambiti territoriali in materia di energia, mobilità, qualità dell’aria, rifiuti, acqua, suolo, natura e territorio, assume carattere di ineludibilità per la programmazione degli interventi e la sensibilizzazione e il
coinvolgimento dei cittadini.
Il III RAPPORTO APAT SULLA QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO, presentato oggi dal Commissario Straordinario dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente, Giancarlo Viglione, alla presenza del Ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio e del Ministro dei Trasporti Alessandro Bianchi, affronta questi temi riferiti alle città capoluogo di provincia con popolazione superiore a 150.000 abitanti.
Sono intervenuti all’incontro i sindaci Walter Veltroni (Roma), Michele Emiliano (Bari) e Umberto Scapagnini (Catania), il presidente dell’ANCI Leonardo Domenici e il presidente della Provincia di Napoli Riccardo di Palma.
Sintetizzando alcuni degli indicatori, illustrati più dettagliatamente nel Rapporto, ci è dato di avere informazioni più dettagliate su cinque capitoli Qualità dell’aria & emissioni, Trasporti, Verde urbano, Acqua e rifiuti.
Vediamo più da vicino i dettagli dei primi due comparti d'analisi.
– Qualità dell’aria & emissioni: per le concentrazioni di PM10, ozono e biossido di azoto nel periodo 1993-2005 nessuna chiara tendenza alla diminuzione. Già a fine giugno 2006 nel 77% dei punti di osservazione è stato superato il valore limite giornaliero della concentrazione di PM10. Per l’ozono, nel 2005, nel 75% degli agglomerati è stata superata almeno una volta la soglia di informazione al pubblico. Nel 2005 si sono registrati nel 95% degli agglomerati superamenti del limite annuale di concentrazione del biossido di azoto che andrà in vigore nel 2010.
Il trasporto su strada costituisce la principale sorgente emissiva di PM10 per più della metà delle città considerate. Per Roma il contributo stimato del trasporto su strada sul totale delle emissioni di PM10 è pari al 70%. Il contributo del settore industriale è consistente in particolar modo per i
comuni in cui sono localizzati grandi poli industriali: Taranto (93%), Venezia (75%) e Genova (49%).
Il trasporto su strada è la principale sorgente emissiva anche per gli altri inquinanti che contribuiscono alle alte concentrazioni di PM10, ozono e biossido di azoto.
Più confortante la situazione relativa alle concentrazioni di monossido di carbonio, benzene, piombo e biossido di zolfo che, dL'analisi delle serie storiche dal 1993 al 2005, risultano essere ormai sotto controllo con pressoché nessun superamento del limite per monossido di carbonio, piombo e biossido di zolfo e un trend decrescente, oramai consolidato, per il benzene. In particolare, per il 2005 risulta la totale assenza di superamenti per il monossido di carbonio, piombo e biossido di zolfo mentre superamenti del valore limite per il benzene che andrà in vigore nel 2010 sono stati registrati nel 25% delle aree urbane analizzate.
– Trasporti: si rileva che il parco autovetture continua a crescere nelle 24 realtà urbane, soprattutto a livello dei comuni di prima e seconda cintura: in particolare in molte città del Centro-Sud si registra una crescita rispetto al 1996 superiore al 20%. Nel 2005 il parco auto di Roma è cresciuto al ritmo di circa 3 auto L'ora! Il numero di autovetture pro-capite rimane tra i più alti d'Europa anche a livello dei singoli comuni. Quasi tutte le città superano la quota di 500 autovetture ogni 1000 abitanti. Molte superano quota 600, e Roma arriva a 732 autovetture per 1000 abitanti: in Europa – Italia esclusa – solo 6 città su più di 160 superano la soglia di 500 autovetture per 1000 abitanti.
Il parco motocicli (cilindrata superiore a 50 cc) risulta in crescita in tutte le aree urbane considerate. In molte città, il numero di motocicli è più che raddoppiato nel 2005 rispetto al 1996: gli incrementi percentuali vanno da +63% a Torino a +176% a Roma.
Il trasporto pubblico locale è caratterizzato da un alternarsi di luci – miglioramento qualitativo del parco mezzi, diffusione dell’uso di carburanti alternativi e dispositivi atti a ridurre le emissioni, diffusione dei sistemi di trasporto pubblico a chiamata con rapida crescita di domanda e di gradimento, sviluppo dell’integrazione tariffaria – ed ombre – carenza di risorse pubbliche disponibili, carenze infrastrutturali, costi operativi in crescita, bassa competitività in termini di rapidità del servizio. La quota di mezzi di superficie alimentata a gasolio rimane assolutamente dominante, dal 60% a Parma al 99,9% di Reggio Calabria, ma si evidenzia quasi ovunque un incremento delle percentuali di vetture meno inquinanti EURO 2 e EURO 3, dell’uso di carburanti alternativi con minori emissioni e dispositivi atti a ridurle.
I mezzi di trasporto a trazione elettrica sono diffusi principalmente nelle grandi città: Milano con circa il 40 % della flotta di superficie, Torino con il 21%, Bologna 17%, Roma 10%, Napoli 14%; i filobus tuttavia sono diffusi anche in città medio – piccole (Modena 15 % della flotta, Parma 16%, Cagliari 18%).
Le linee metropolitane sono presenti attualmente solo in un ristretto numero di città: L'estensione complessiva della rete italiana (168 km) è meno della metà rispetto a quella della sola città di Londra (408 km), ed inferiore a quella di altre importanti capitali europee come Madrid (179 km).
Il mobility management, nelle 24 città con numero di abitanti maggiore alle 150.000 unità, è stato intrapreso in ben 23 città; tuttavia non in tutte risulta pienamente operativo. In Europa il 30 % dei tragitti effettuati quotidianamente in auto copre distanza inferiori ai 3 km ed il 50% è inferiore a soli
5 km. Anche solo a questo livello, la bici potrebbe vantaggiosamente sostituire l’autovettura per una parte importante della domanda e contribuire quindi a diminuire la congestione.
La situazione della ciclabilità urbana in Italia è una vicenda di chiaroscuri. Dall’indagine svolta emerge comunque una dotazione infrastrutturale largamente insufficiente (mediamente 8077 abitanti per ogni km di pista ciclabile: dai 1633 abitanti per km di Brescia ai 16.460 abitanti per km di Livorno). La città dove è maggiormente diffuso L'uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani (modal split) è Parma (tra il 21 e 25% degli spostamenti complessivi) seguita da Padova (tra l’11 e il 15%), mentre Roma, la più grande città italiana, si trova sotto il 5% e Torino con Firenze e Bologna tra il 6 e il 10%.
III Rapporto Apat sulla qualità delL'ambiente urbano
Manu Mich. – clickmobility.it

















 Clickmobility:
Clickmobility: